QUARESIMA NELL’ARENA DEGLI HUNGER GAMES #23 MARTIRI
Mi mordo il labbro inferiore. Mentre io stavo elucubrando sull’arena e sulla disponibilità di alberi, Peeta era alle prese con il problema di conservare la sua identità. La purezza del suo io. “Vuoi dire che non ucciderai nessuno?” chiedo. “No. Quando arriverà il momento sono sicuro che ucciderò come chiunque altro. Non posso darmi per vinto senza combattere. Solo continuo ad augurarmi di trovare un modo per…per dimostrare a quelli di Capitol City che non sono una loro proprietà. Che sono più di una semplice pedina” dice Peeta. “Ma non lo sei” obietto. “Nessuno di noi lo è. E così che funziona il programma”. “Bene, ma all’interno di quella struttura, tu sei ancora tu, io sono ancora io?” insiste. “Più o meno. Solo che… senza offesa, ma chi se ne frega, Peeta?” chiedo. “Frega a me. Voglio dire, di cos’altro mi è permesso di preoccuparmi, a questo punto?” chiede con rabbia. Adesso ha gli occhi azzurri fissi nei miei, esige una risposta. Faccio un passo indietro.
Hunger Games, libro I, capitolo 10
Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. […] Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”. “Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua”
Giovanni 4: 10,13-14
Si parla di morte, eppure questo è il dialogo più vivo di tutto il libro.
Ad uno sguardo sulla propria morte imminente e violenta, Peeta risponde, anzi esige da se stesso, uno sguardo alla vita eccezionalmente autentico.
Quando si dice “un eroe”.
Guardare in faccia alla fine e continuare a sentire un’impetuosa spinta alla verità della propria esistenza.
“Di cos’altro mi è permesso di preoccuparmi?” è la domanda che dovrebbe scaturire, ogni volta, al nostro terrore di fronte alla morte.
Non sappiamo nulla di domani, di quello che ci avverrà tra un’ora o dieci minuti, anche il presente, gli stessi attimi che si rincorrono, sfuggono al nostro controllo e scivolano dalla nostra clessidra, da questo involucro di vetro che ci appartiene ma di cui non abbiamo speranza di contare i granelli di sabbia, solo di coglierne il ritmico scorrere.
Non ci è permesso preoccuparci della nostra morte, del come, del quando e del perché: allora, di cosa ci è permesso occuparci?
Di ciò che rimane.
E non parlo di ricordi, di memoria, di testamenti e sistemazioni.
No, parlo di qualcosa di concreto: la nostra anima.
Peeta di fronte alla certezza di morte, si preoccupa di ciò che conta davvero: rimanere integro, appartenere alle proprie radici, alla propria storia, non farsi sradicare la sua essenza, la sua persona, o, come diremmo noi, il suo spirito. E non è questione di peccato mortale, di difendersi, di trovarsi in situazioni da “mors tua vita mea“.
Ogni giorno possiamo viverlo come assassini senza per forza uccidere nessuno: lapidandolo a parole, sotterrandolo vivo senza un mormorio, guardandolo scavarsi la fossa incuranti di tiralo fuori, passando oltre mentre soffoca tra le ossessioni, dandogli uno spintone nel baratro dei sensi di colpa.
No, non siamo migliori di chi si troverà in quell’arena.
Eppure ci sono loro, i “Peeta” della nostra vita, che ci obbligano a chiederci di chi siamo, a chi apparteniamo, cosa c’è scritto sull’etichetta invisibile della nostra vita, quella dietro il collo delle maglie con il nome di fabbrica: “proprietà di…“.
E ci sono i martiri,
i soli che sono riusciti a leggere quell’etichetta e ritrovarsi davanti alla morte con una risposta talmente chiara da non avere bisogno di porsi la domanda nel momento cruciale: “fatto da Dio“.
Un Padre che è l’Infinito, la risposta che spiega quello strappo che ci sentiamo dentro, che dà significato alla voglia di immenso che si cela in ogni nostra gioia, in ogni nostro desiderio, che rimette in ordine tutti gli scomparti della nostra vita per poi alzare l’asticella e renderci coscienti che sappiamo saltare ancora più in alto, che abbiamo sempre saputo farlo ma non ne eravamo consapevoli.
Lo stesso Padre che apre tutti i cassetti del cuore di cui avevamo perso le chiavi, che riordina, rassetta e toglie le persiane in quelle stanze dove noi non avevamo neanche immaginato esistesse una finestra, che sa ricucire ferita e rompere ossa da raddrizzare, che ha una farmacia miracolosa dal nome “Misericordia” senza orari di chiusura o pausa, dove a servirti c’è proprio Lui che ti consegna anche la ricetta e non si fa pagare mai.
La sete di assoluto che non sappiamo spiegare, che ci perseguita dalla nascita e ci lascia agonizzare per sentire almeno una goccia di verità pura, quella stessa sete che il demonio sfrutta per ricacciarci ogni volta nella piccolezza insignificante della nostra anima, nella nullità delle nostre forze.
Quella sete lì, Lui ha promesso di dissetarla: non solo una volta, non “per un pò”, ma per sempre.
Questo vuol dire essere “fatti da Dio“: è essere infinitamente di più di ciò che ci aspettiamo, essere all’altezza del Cielo, stagliarsi di fronte all’infinito e dire “eccomi, tutto questo fa parte di me, mi è stato dato in eredità, mi appartiene perché mia proprietà!”.
Peeta è “fatto da Dio” perché sa di non appartenere a chi si arroga il diritto di possedere la sua vita e la sua morte: i martiri sono “fatti da Dio” perché non appartengono più al mondo, non dipendono dalla volontà dei loro carnefici che stringono la loro vita tra le mani, perché sanno a chi appartiene la loro esistenza, il loro essere infinito.
E allora non siamo più “oggetti” in balia di folli con manie di onnipotenza, ma eredi di un’esistenza infinita, perché figli di Dio.
Ma dobbiamo sapere che farcene, di questa figliolanza.
Dobbiamo avere la forza di rivendicarla, di farcene carico, di prenderci la nostra responsabilità.
L’onere dell’eredità.
Anche la consapevolezza che la nostra anima non si svende, che possono prenderci tutto, ma non lo spirito, non la nostra vera natura, l’essenza eterna di papà-Dio in noi.
Siamo chiamati ad essere di più, a guardare lontano, anche oltre la nostra vita che sembra essere il nostro tutto, e invece non lo è: dobbiamo farci le giuste domande anche di fronte alla morte, come Peeta, e non solamente “quanti minuti mi restano“, come faremmo noi. Siamo chiamati a non essere Katniss, a non fare un passo indietro davanti alle domande importarti dell’esistere.
Anche davanti ai punti interrogativi degli adolescenti, ed ancor più dei bambini: esistenza, bene, responsabilità, male, vita, morte, significato.
Quanto coraggio ci vuole, per non scendere a compromessi: in questa coerenza, Peeta è il nostro modello da seguire, la nostra ambizione.
Perché è facile svendere il proprio passato, nel mondo. Fingersi qualcosa che non siamo, per barattarlo con una manciata di “presente” che non ci appartiene.
Peeta non ci sta: non si venderà, non cambierà chi è.
Rimarrà Peeta, così come Rolando è rimasto se stesso.
Rolando Rivi: disprezzato dai partigiani per la sua tonaca e il suo amore per Dio, accusato di essere spia dei fascisti per mettere a morte la sua vita scomoda.
Deriso per quella veste che i suoi genitori gli scongiuravano di abbandonare, quella fede che volevano ammazzare per provare a dissetarsi col sangue di chi non potevano spezzare, neanche con le sevizie.
La sua vesta da seminarista, seppur quattordicenne, non l’abbandonò mai e la lavò nel sangue delle torture: “Non posso lasciare la mia veste: è il segno che io appartengo al Signore“.
Sapeva “di chi era” fin d’allora, e di chi è tutt’ora la sua anima immortale.


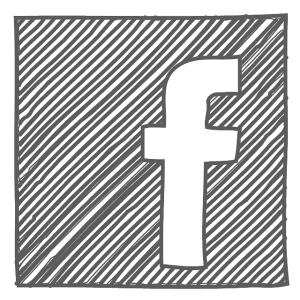


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!