Quaresima con Tolkien #26 – CANCELLO DI MINAS TIRITH
“…a promulgare […] il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell’abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto.“
Dal libro del profeta Isaìa
<<Allora il Capitano Nero si rizzò sulle staffe e urlò con voce spaventosa, pronunciando in qualche ignoto linguaggio parole di potere e di terrore tali da lacerare cuori e rocce. Urlò tre volte. Tre volte rimbombò il grosso ariete. Ed improvvisamente all’ultimo colpo il Cancello di Gondor cedette. Come colpito da un lacerante maleficio, lo si vide saltare in aria: vi fu un lampo di luce accecante ed i battenti crollarono in terra frantumati in mille pezzi. Il Signore dei Nazgûl entrò sul suo cavallo. Si ergeva immenso, un’enorme figura nera contro il bagliore degli incendi, una terribile minaccia di disperazione. Il Signore dei Nazgûl si fece avanti, varcando l’arco che mai nemico aveva oltrepassato, e tutti fuggirono innanzi a lui.>>
Il Signore degli Anelli, Il ritorno del Re, libro I, cap. IV, “L’Assedio di Gondor”.
Le ultime tre grida, gli ultimi tre colpi inflitti dal possente ariete, sembrano quasi scandire un tragico conto alla rovescia.
Sembrano le tre “pugnalate” che Pietro infligge a Gesù: i “non lo conosco” gridati nella notte.
E come biasimarlo: chi riconosce Gesù, nelle notti dell’anima? Eppure, parafrasando, era stato anche avvisato: “Dare la vita per me, tu? (momento di meme flash che scorre nella mente di Gesù) ma se per tre volte ti scorderai pure di come mi chiamo!”. Se la parte “uomo avvisato mezzo salvato” ce la ricordiamo bene, c’è un trafiletto che spesso può passare inosservato: “Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli”. Gesù non è un veggente da strapazzo dell’ultimo minuto, e Luca riportando queste parole ce lo conferma. Sapeva già da tempo. Sapeva che razza di persone aveva intorno. Sapeva di che pasta siamo fatti noi, i suoi nuovi seguaci.
Sapeva perfettamente quando mi sarei scordato di tutte le grazie ricevute, per puntare i riflettori sulla miseria che ora scardina tutti i picchetti. Sapeva che sarei entrato nel mio personale purgatorio privato dove incombe su di me il peso dell’assenza. Un peso per ognuno diverso, ma non per questo meno gravoso: salute, lavoro, amore, significato.
Il paradiso, al contrario, è pienezza in abbondanza: dove ci riconosciamo saturi e traboccanti della sua presenza, dove ogni vuoto è colmato e non c’è più nulla che deve essere riempito, perché lui occupa ogni luogo del nostro essere.
Come la prima volta, quando lo vede armeggiare con le reti vuote e lui le riempie, così ora, è Gesù che “trova” Pietro, nella sua insoddisfazione di dover accettare un leader che si consegna ai suoi aguzzini in attesa di farsi ammazzare, in quei tre chicchirichì che gettano l’apostolo nello sconforto, in quello che suona come un “te lo avevo detto”, ma non è una rivendicazione, un modo per metterlo faccia a faccia con la sua piccolezza, ma più una sveglia.
Pietro è uno di noi,
uno a cui non è bastato vedere miracoli ed ascoltare la vita che usciva bocca di quell’uomo: Pietro vuole la strada a modo suo, Pietro ancora non si fida. Gesù non si dà per vinto: sa che il discepolo non è ancora all’altezza di quell’amore, come del resto non lo siamo noi, e non rimane scandalizzato dal suo peccato, anzi, rinnova il suo amore proprio annunciandogli il suo tradimento senza provarne disgusto o ripudiandolo.
In quel dialogo Gesù sembra dirgli: “So che non sarai con me fino alla fine, so che ti girerai quando la strada si farà difficile, quando la vita prenderà una piega che non vuoi, quando non capirai il senso, nonostante il mio “esserci” nella tua storia, o magari, a maggior ragione, proprio perché mi vedrai inerme e passivo di fronte al male. Perché so che non sei ancora pronto. Sappi che io non ti odio per questo, che la tua fragilità non cambia ciò che provo per te, non ti rende meno meritevole del mio sangue: morirò per te perché ti amo anche nella tua imperfezione, nel tuo errore più meschino del tradirmi e fuggire”.
Non è il peccato che scandalizza Dio, piuttosto cosa decidiamo di farne, di quel peccato, che strada intendiamo prendere all’ennesimo inciampo: “io ho pregato per te”.
Dio, nella sua immensità, si occupa dei nostri errori, “popolo di dura cervice”, perché Pietro usi quell’opera del male e ne tragga il suo bene: “una volta convertito”, come se tra le righe e i silenzi potessimo leggere, “perché ora non lo sei, non sei ancora uno che mi ama, sei solo un curioso, in cerca delle promesse del mondo, per riempire tutti i tuoi vuoti con un messia che ordini la tua vita, qualcuno che ti dia le redini della tua esistenza e ti doni abbondanza di grazie”, #solocosebelle insomma. Eppure, se ci facciamo plasmare, lui sceglie sempre noi, nonostante tutto, e dona alla nostra imperfezione nuovo senso, dandole un significato: “conferma i tuoi fratelli”. Perché i peccati commessi, le ferite che ancora sanguinano, le piaghe che nascondiamo, non siano l’ultima parola. Come disse alla peccatrice “Coraggio, non ti giudico, è vero hai sbagliato ma ora che vuoi farne di questo dolore? Sta a te decidere da adesso, come riscrivere la tua storia, e io ti dico va’ e non peccare, perché ti amo e non sarà questo a scandalizzarmi, ma il tuo provare a camminare che mi riempirà di gioia”. Tutti noi siamo Pietro, in balia delle nostre giornate, pronti a girarci e fuggire quando il gioco non vale più la pena. E se capitasse, ancora e ancora, se commettessimo un peccato che ci facesse vergognare di noi, non lasciamoci ingannare, lui di noi non proverà mai vergogna.
Giuda non è condannato nel tradimento, ma nel perseverare nell’inferno personale che si è creato, quello che Gesù leggeva nitido nel suo cuore.
Giuda e Pietro sono nello stesso piano, ma uno trae umiltà e speranza, uno inferno e disperazione.
Quando si spalancano le nostre porte a quel Cavaliere Nero, quello che assedia sempre il nostro cuore e alla fine, vuoi perché il tempo ci fiacca, vuoi perché qualunque portone ha un punto debole e bastano dei colpi ben assestati, a quei peccati che ci fanno chiedere “ma come sono caduto così in basso?”, non lasciamogli l’ultima parola. Lui, nel nostro confessarli, li ha già perdonati, ma noi dobbiamo decidere cosa farne, che utilità trarre da quegli ingredienti. Gandalf stesso non sa se sia all’altezza, non è certo di poter vincere con le sue forze, ma nonostante tutto non fugge, non lascia alla disperazione l’ultima parola: quel giorno che sorge è lì per noi, mentre ci ergiamo in piedi davanti a tutto quel male. Cresciamo, facciamoci forti del nostro “averci delusi” per trasformare tutto in sincera carità, per riscoprirci più umili, più fragili, più bisognosi di quel “io ho pregato per te, una volta convertito conferma i tuoi fratelli”.
Quel gallo che canta non sia l’annuncio della nostra maledizione, la condanna che ci infliggiamo e che ci inchioda al nostro peccato. “Il Signore, voltatosi, guardò Pietro”: lo sguardo di Dio ci aspetta oltre quel tradimento, oltre ogni nostra piccolezza.
Perché non sia del Cavaliere Nero l’ultima parola, perché oltre quei tre canti nel buio, sappiamo vedere la luce che torna e invade le tenebre.
Lui ci aspetta proprio lì, per difenderci dall’accusatore, per strapparci alla morte che ci siamo inflitti. Quel gallo sia segno di svolta, sia annuncio di un’alba nuova, del suo posare i suoi occhi su di noi, motivo di rinascita, di conferma che persino il nostro Dio non si è scandalizzato, mentre ancora siamo ricoperti di peccato, ma ci chiede di svoltare. Ci chiede di trasfigurare il male e trarne il nostro bene, la nostra salvezza: ogni peccato, una svolta d’amore.
<<Tutti eccetto uno. In attesa, immobile e silenzioso in mezzo allo spiazzo del Cancello, sedeva Gandalf su Ombromanto: Ombromanto, l’unico dei liberi cavalli della terra capace di tollerare il terrore, impassibile, risoluto come un’immagine scolpita a Rath Dinen. “Non puoi entrare qui”, disse Gandalf, e l’enorme ombra si fermò. “Torna negli abissi preparati per te! Torna indietro! Affonda nel nulla che attende te ed il tuo Padrone. Via!”. Il Cavaliere Nero fece scivolare il cappuccio e, meraviglia! portava una corona regale; eppure sotto di essa vi era una testa invisibile, poiché fra la corona e le grandi e scure spalle ammantate brillavano rossi i fuochi. Da una bocca inesistente proruppe un riso micidiale. “Vecchio pazzo!”, disse. “Vecchio pazzo! Questa è la mia ora. Non riconosci la Morte quando la vedi? Muori adesso, e vane siano le tue maledizioni!”. E con ciò levò alta la spada e delle fiamme ne percorsero la lama. Gandalf non si mosse. In quell’istante, lontano in qualche cortile della Città, si udì il canto di un gallo. Era limpido e chiaro, ignorava la magia e la guerra, non faceva che acclamare il mattino che su nel cielo, oltre le ombre di morte, si avvicinava con l’alba. E come in risposta giunse da lontano un altro suono. Corni, corni e corni. Si udivano fiochi echeggiare nei fianchi del cupo Mindolluin. Grandi corni del Nord che suonavano con forza. Rohan era finalmente arrivato.>>
Il Signore degli Anelli, Il ritorno del Re, libro I, cap. IV, “L’Assedio di Gondor”.


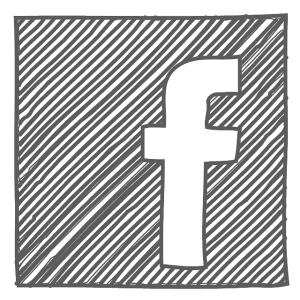


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!