Si può vivere senza un sogno?
Si può morire a nove anni?
Si può morire a nove anni per un’infezione, per un piatto vuoto, per un bicchiere asciutto?
Si può morire di freddo nella notte, o per strada vicino all’immondizia?
Si può morire per la mancanza di amore o per il troppo amore, a nove anni?
E per un sogno, si può morire?
In questa vita “io” centrica dove vita e morte ci sembrano giochi nelle nostre mani, cosa sappiamo davvero, noi?
Sappiamo che se è nel grembo, è un grumo.
Sappiamo che se soffre, è da mettere in pace.
Sappiamo che se non ha memoria è un vuoto a perdere.
Sappiamo che senza comunicare, non è vita degna.
Come siamo stati bravi, noi gente moderna del XX secolo, a cogliere da quell’albero del bene e del male: a disinfettare da ciò che non è visibile agli occhi, ad affettare la realtà, a sbucciare quello che ci fa più comodo,
a dispensare fette di nozioni e termini, imbanditi su piatti rigorosamente “inclusivi&inoffensivi”, ad imbavagliare bocche con tovaglioli candidi e offrire calici di notizie frizzanti dai casi estremi che giustifichino l’ingorda pappata di bugi che ci facciamo, per digerire meglio il tutto.
In questo marasma di stomaci rigirati, ogni giorno ci interroghiamo ed ogni giorno sperimentiamo quanto il mistero del creato sia fuori dalla nostra portata.
Perché la domanda che oggi ci poniamo è:
si può morire a nove anni per un sogno?
Come Lorenzo Somaschini, un piccolo prodigio argentino, morto mentre faceva ciò che amava: le prove libere della gara di Junior Cup, categoria della Superbike Brasile, ad Interlagos.
Di primo acchito, il no sarebbe assicurato, che ci sono cose inevitabili e cose che possiamo dribblare, che è dovere di un genitore fare scelte sane e tutelare in ogni modo possibile la vita di un figlio.
Allora vi giro un’altra domanda: si può vivere a nove anni e per tutta la vita, senza un sogno?
No, non chiedo di darmi una risposta, ma, per un attimo, di provare un modo nuovo di vedere una tragedia senza rimedio: cosa sarebbe successo se la vita fosse finita in un treno che portava in vacanza, oppure in una festicciola tra amici.
La gogna mediatica che stanno riservando ai genitori di “Lolito” sarebbe stata la stessa? Avrebbe avuto la stessa enfasi? Ci saremmo comunque avventati contro come belve contro questi cuori di padre e madre, già a brandelli?
La vera domanda è quale linea sottile tracciamo tra la nostra volontà, quella dei nostri bambini, e le strade che il Signore apre per noi.
Tutti i genitori del mondo si fanno la stessa domanda, per primi Eva ed Adamo che si sono ritrovati primi al mondo con questa novità assurda, una bella gatta da pelare tra le mani: la morte.
Mai vista, mai sfiorata, mai conosciuta, si è agguantata sul loro figlio senza lasciare loro il modo di digerire, di prepararsi, di darsi una risposta, aggiungendo tragedia alla tragedia per la scelleratezza di quel Caino tanto amato.
Anche oggi, anche senza Caino, anche nei modi più assurdi, c’è una lotta che in noi ci strazia: giusto e sbagliato, fare o non fare, trattenere o accompagnare.
I genitori di Lolito hanno accompagnato: si sono presi carico dei sogni grandi del figlio, della sua passione, della sua dedizione, della sua bravura, di una capacità unica che Dio gli ha donato.
Cosa rimane?
Un dubbio atroce: se non fosse stato, se non avessero spronato, se avessero negato quella qualità, cosa sarebbe successo?
Ma, al contrario, se quella moto avesse salvato, o allungato, la sua vita?
Se lo avessero tirato per i capelli da un destino diverso, se lo avessero portato il più distante possibile da un’altra morte: se al contrario del Cavallo di Samarcanda, proprio queste stesse due ruote lo avessero allontanato il più velocemente possibile da un’altra fine ancora più prematura?
Ovvio, disquisiamo di assurdità.
E come tali, ci fanno capire perché questo è il motivo per cui l’uomo non ha il permesso di mangiare del frutto dell’albero: solo Dio sa.
Da scellerati a pazzi, da incoscienti a menefreghisti, non si accetta che questi genitori abbiano fatto correre questo rischio, come se loro non l’avessero ponderato, come se non fosse stato oggetto di dubbi ed angoscia per entrambi, in ogni corsa.
Perché se non è la velocità, è l’altezza, se non è l’altezza è la forza, se non è la forza è la pressione: ogni nostra azione che “esce” dai canoni di sicurezza e controllo, ci appare assurda, e da escludere per chi non ha la maggiore età e non può scegliere per sé stesso in modo completamente autonomo e autogestito.
Eppure quanta grandezza avrebbe perso il mondo rincorrendo solo questa certezza di autodeterminazione estrema, fino alla fine.
Ma i genitori sono invece chiamati a delle scelte, al puntare in alto, ad osservare ciò che Dio ha messo nelle loro mani e accompagnare nel modo migliore, secondo la grandezza specifica che Dio ha messo nelle capacità di questo essere che ci è affidato.
A noi basta la certezza del suo amore, della sua misericordia, del suo paradiso.
Certo, il dubbio atroce resta, ma a me resta anche una certezza: quel bambino aveva cucito addosso il coraggio di chi crede in te e non ti “castra”, non ti “tarpa le ali”, di chi sa che sei figlio ma sa che sei anche altro di totalmente nuovo, totalmente diverso, totalmente unico e, per i cristiani, totalmente appartenente a Dio.
Quel bambino vedeva riflesso nei suoi occhi lo sguardo di chi, amandoti, vede la tua grandezza anche se racchiusa in un formato pocket, e per un cristiano, di chi sa che non siamo veramente “dei nostri genitori” ma abbiamo una strada tutta nostra da percorrere, o magari su cui sfrecciare perché allenati, capaci, felici.
Non c’è riposta, non c’è pace, ma la certezza che la grandezza è stata vissuta, anche in una vita breve: l’immenso privilegio di essere guardati dai nostri genitori per quello che siamo davvero, non per quello che loro vorrebbero, sognando insieme, per il tempo che Dio, nel suo mistero e nella sua misericordia, ci concede.


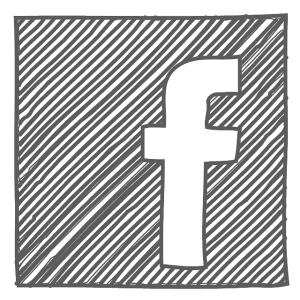


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!